L’ombra di Serena – Mezza Riga n. 11
A dieci anni dal Grande Slam mancato, nessuna giocatrice sembra capace di raccoglierne l’eredità, né nei risultati né nella solidità di gioco. Una dominatrice come lei non si intravede all’orizzonte
Testo di Giorgia Mecca
Illustrazione di Davide Bonazzi
Dieci anni fa, a New York, stava per accadere una cosa che non accadde mai.
Edizione numero 135 dello US Open: con tutto il rispetto per gli altri 255 giocatori in tabellone, Flushing Meadows stava per trasformarsi nel set del trionfo di Serena Williams. Quell’anno anche Djokovic, Federer e Nadal fanno un passo indietro, sono attori non protagonisti, nel Queen’s sta per andare in scena quello che chiamano il Serena’s Slam. Qui si fa la storia e la storia sta per farla una donna nera di trentaquattro anni. In quella stagione l’americana ha vinto Melbourne, Parigi e Londra, le manca l’ultima città, dove sedici anni prima, nell’ultimo major del vecchio millennio (e del mondo prima dell’arrivo delle due sorelle), ha scagliato la prima pietra. Le mancano sette partite per conquistare il Grande Slam, la vittoria di tutti e quattro i tornei più importanti della stagione (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open). L’ultima a riuscirci era stata Steffi Graf nel 1988, tra gli uomini Rod Laver nel 1969.
Serena Williams, ragionevolmente, preferirebbe non pensare a ciò che sta per accadere, ma in quei giorni la sua faccia è ovunque: i suoi sponsor la ringraziano, festeggiano con settimane di anticipo; per la prima volta i biglietti della finale femminile costano più di quelli della finale maschile. Lo chiamano effetto Serena. Sì, ma Serena dov’è? Entra al circolo ogni mattina prima dell’apertura dei cancelli, l’unica compagnia che accetta volentieri è quella del suo cane Chip. Todd Heisler, il fotografo incaricato dal New York Times di seguire i momenti che precedono la gloria, fuori dai match ufficiali, non riesce a scattare foto che non siano quelle in cui lei ha gli occhi fissi sui suoi piedi. Dopo Parigi, quando la parola Grande Slam è diventata pronunciabile, hanno cominciato a farle la domanda: cosa faresti se dovessi vincerlo? Lei si nasconde sempre dietro a un no comment; a New York però risponde: “Farò un lunghissimo respiro, e poi scomparirò”. È il pensiero di una donna in apnea, esausta, che nel raggiungimento del traguardo più importante per un giocatore riesce ormai soltanto a vedere la conquista del diritto a eclissarsi, sparire, non farsi più vedere dentro un campo da tennis. Nella stagione 2015, fino a quel momento, la statunitense ha giocato 50 partite e ne ha perse soltanto due (contro Petra Kvitová a Madrid e contro Belinda Bencic a Toronto). Oltre agli Slam ha vinto i tornei di Miami e Cincinnati, programmando con cura il calendario per farsi trovare pronta. Ti consideri la migliore tennista della storia?, le domandano i giornalisti. “Mi considero la miglior versione di me stessa”, risponde lei. Sì, non può dirlo, ma si considera la miglior tennista della storia, e in quella stagione nessuno oserebbe contraddirla. Non si tratta soltanto di essere numero 1 al mondo da 130 settimane consecutive, ma di essere diventata un territorio inespugnabile. Sai quando vince i match Serena Williams? Quando ti passa davanti nei corridoi prima di entrare in campo, concordano le avversarie. Non è il suo gioco, non soltanto almeno: è la sua stessa presenza. Serena occupa tutto lo spazio.
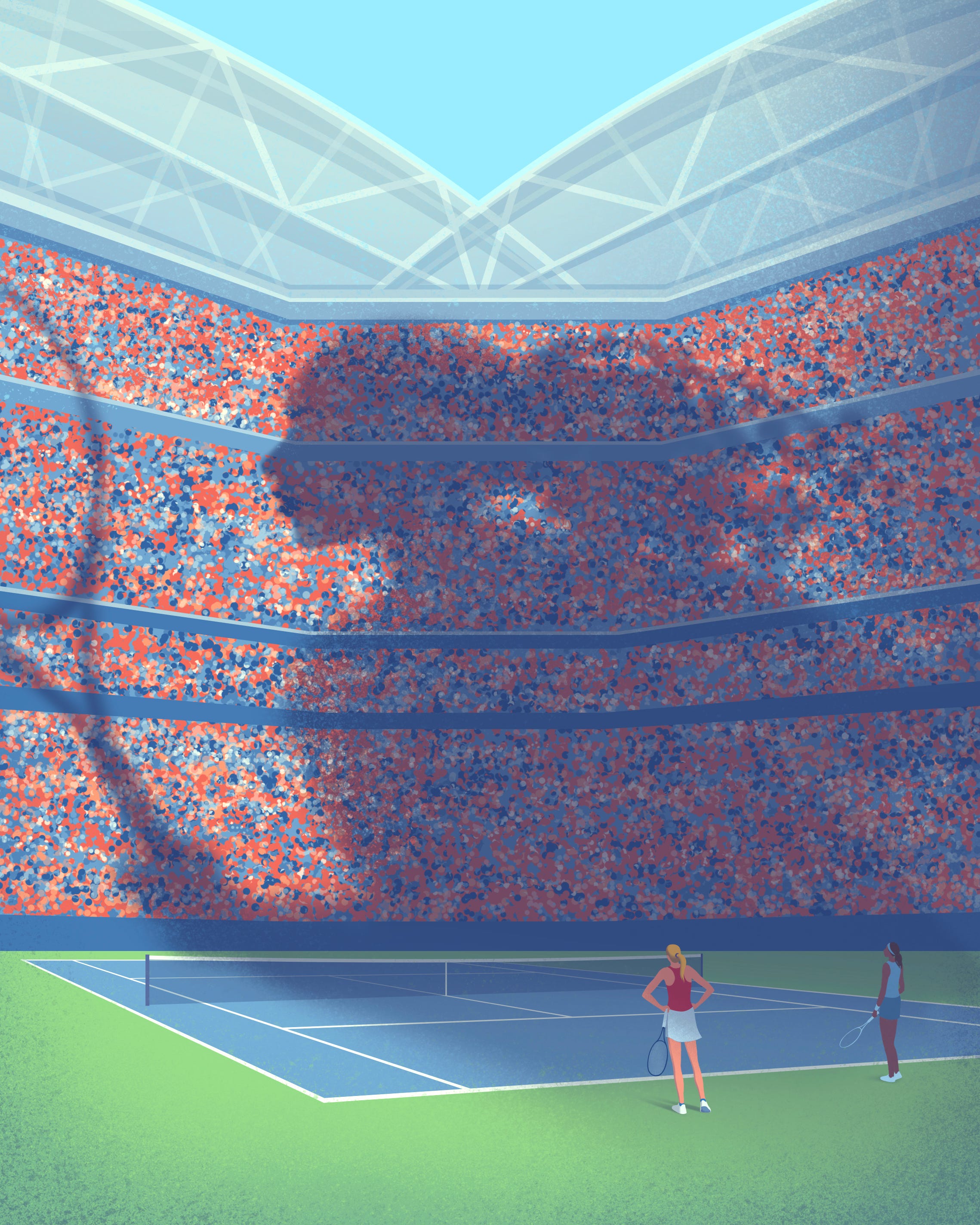
A New York, in quei giorni, nessuno è prudente e nessuno è scaramantico. Soprattutto, nessuno la guarda in faccia per provare a capire come sta.
La prima volta che è stata prima in classifica era l’8 luglio 2002, dopo la vittoria a Wimbledon contro sua sorella Venus, sconfitta e buttata giù dal podio dalla sua versione in miniatura. Ora Serena è la prima giocatrice del ranking dal febbraio 2013 (lo rimarrà fino all’11 settembre 2016, un anno dopo). In tutti questi anni ci sono state giocatrici che le hanno rubato la scena: Maria Sharapova, Caroline Wozniacki, Angelique Kerber. Tutte e tre hanno affrontato l’americana e l’hanno anche sconfitta, ma alla fine loro si sono perse e lei è rimasta. La sensazione che lascia il tennis degli anni Duemila è che il resto del circuito sia una comparsata all’interno del suo one-woman show, il Serena Show, come lo aveva battezzato anni prima Richard Williams, l’artefice della rivoluzione. Il papà delle due sorelle è assente in quei giorni, ma senza di lui non esisterebbe niente di tutto quello che sta per succedere. E che non succederà.
Serena Williams è diventata il tennis femminile, e il sospetto è che le avversarie non servano ad altro che a farla risaltare ancora di più. È il giorno della semifinale. Mancano due match per annullare le statistiche, i paragoni, per concludere il dibattito su chi sia la più forte giocatrice di tutti i tempi, e Serena, vista da lontano, è too big to fail. E infatti fallisce in modo eclatante, Serena’s way. Ci sono due immagini che rimarranno di quel pomeriggio di fine estate glorioso per il tennis italiano (Flavia Pennetta qualche ora prima aveva sconfitto Simona Halep conquistando la finale): le mani di Roberta Vinci che chiede gli applausi al pubblico dell’Arthur Ashe, lo stadio da tennis più grande del mondo, e poi il petto di Serena Williams contro il telone di bordocampo, la sua testa oltre il box dei fotografi. Per il tennis americano è la peggior sconfitta del millennio e rappresenta il tramonto della Serenissima, la fine dell’impero. Da allora ci sarebbero stati altri Slam, altre finali, altre cadute e altre campionesse messe in ombra dalla sua presenza. Ma in quella data, l’11 settembre 2015, finisce il dominio, cominciato nel 1997 e terminato due decenni e mezzo dopo, nel 2022, quattro decadi diverse: 23 Slam, 73 titoli, 4 ori olimpici (uno in singolare e tre in doppio), oltre mille match giocati e un bilancio di 858 vittorie e 156 sconfitte, 319 settimane in cima al ranking, di cui 186 consecutive.
A dieci anni esatti da quel Serena’s Slam mai avvenuto è lecito chiedersi chi sia la sua erede, e soprattutto se se ne veda qualcuna all’orizzonte. Dalla fine del suo regno si sono succedute nove numero 1 nel ranking WTA, ma solo due dal giorno del suo ritiro: Iga Świątek e Aryna Sabalenka. Ed è interessante notare che Świątek sia diventata numero 1 inizialmente non per merito ma per colmare il vuoto lasciato da Ashleigh Barty, l’australiana che nel 2022 si era congedata dallo sport in cui era la migliore al mondo con queste frasi: “Ci sono tanti sogni che non includono il viaggiare per il mondo a giocare a tennis”. Serena ha cominciato a pensare al numero 1 davanti al suo nome quando ancora doveva aiutarsi con la mano sinistra per colpire il dritto e iniziava a provare invidia per la sua adorata sorella; a Świątek, prima di meritarselo più di ogni altra, il primo posto nel ranking è capitato.
Le copertine dei giornali, alla ricerca disperata della next best thing, la donna che avrebbe dovuto garantire il mantenimento del circuito nel dopo Serena, avevano indicato Naomi Osaka e Coco Gauff. Certo, entrambe sono cresciute con il poster delle due sorelle in cameretta; ma è certo anche che entrambe se ne sono dovute liberare per non restarne soffocate.
Osaka, che si autodefinisce donna, nera, asiatica, nei primi anni nel circuito quando doveva affrontare una palla break si faceva sempre la stessa domanda: Cosa farebbe Serena al posto mio? Si incontrano per la prima volta nel marzo 2018, al primo turno del torneo di Miami. Williams appena rientrata dalla maternità, Osaka da numero 22 del mondo. Dopo aver battuto la versione in carne e ossa del poster di quando era bambina, la ventunenne non è riuscita a fare nient’altro che un inchino. Poco dopo ha postato su Instagram una foto con il commento: OMG, Oh my God.
A Gauff è toccato in sorte di essere una predestinata, un privilegio di cui forse avrebbe fatto volentieri a meno, con un fardello pieno di aspettative riposte per il solo fatto di essere giovane, forte e nera nell’epoca post Serena. A livello tennistico Serena Williams e Coco Gauff non hanno nulla in comune. Sarà anche per questo che durante lo US Open 2023 (che poi avrebbe vinto), l’erede designata e riluttante si era fatta fare una maglietta con su scritto “Call me Coco”. Chiamatemi Coco. Sottinteso: Coco e basta.

È come se ciò che è arrivato dopo la rivoluzione made in Williams abbia voluto prendere le distanze, segnare una linea di confine, come se per crescere la nuova generazione sia stata costretta, freudianamente, a uccidere la madre. Serena è un’altra epoca, un altro mondo, un’altra donna. È nata all’inizio degli anni Ottanta, il suo era un sogno americano contorto e rabbioso, fatto di rivalsa, ma pur sempre un sogno (o forse sarebbe più corretto dire che era il sogno di Richard): pensava che il tennis fosse la soluzione, pensava che al mondo non esistesse nient’altro. Osaka e Gauff sono tutta un’altra storia. La prima è nata a fine anni Novanta, la seconda a inizio del Duemila, c’è un mondo stravolto di mezzo. L’avvento dei social network, il Black Lives Matter, la salute mentale e la scelta consapevole di farci caso, quella copertina del Time con la Osaka in primo piano e il titolo: “It’s ok to not be okay”. Il mondo è grande, il campo da tennis solo una piccola parte. Ci si può prendere una pausa, interrompere la vita da atleta prima dei trent’anni per decidere di diventare mamme, non è necessario far diventare la vittoria un’ossessione per essere campionesse, non è necessario essere campionesse se esserlo significa sacrificare tutto il resto.
Il tennis ha nuove campionesse e la Mattel ha creato una nuova Barbie della serie Inspiring Women, la bambola Venus Williams, uscita a metà agosto, poco prima della sua ventiquattresima partecipazione allo US Open, dove ha ottenuto una wild card a quarantacinque anni. Prima di tornare in campo a New York ha giocato il torneo di Washington, dove ha vinto contro Peyton Stearns, ventitré anni e top 50 del ranking, Williams non giocava un torneo da sedici mesi; Stearns nel 2025 ha raggiunto la semifinale agli Internazionali d’Italia.
Il tennis ha nuove campionesse eppure è Serena Williams a comparire nella lista delle cento donne più influenti al mondo, non le sue colleghe ancora in attività. Basta guardarsi intorno e domandare il nome di una tennista a caso: sarebbero in pochi a non fare il suo. Una buona notizia per i nostalgici, qualcosa su cui riflettere per tutte le altre. Dal 2023, la prima stagione senza Serena, si sono disputate undici prove dello Slam che hanno avuto, tra finaliste e vincitrici, tredici giocatrici diverse. Al contrario di ciò che succede tra gli uomini, dove all’epoca dei Big 3 non si è sostituito il caos ma si è creato un nuovo ordine, la Sincaraz, con tutto il resto del mondo fuori dalla corsa Slam da quasi due stagioni, nel tennis femminile sembra mancare la consistenza.
Coco Gauff è la seconda giocatrice più forte del mondo. Lo scorso luglio a Montreal, uno dei tornei di preparazione per lo US Open, in un match di primo turno contro Danielle Collins, ha commesso 23 doppi falli, pur riuscendo comunque riuscita a vincere il match. Aryna Sabalenka, la numero 1 del mondo, non vince un torneo dallo scorso maggio, il Masters 1000 di Madrid. Al Roland Garros è stata sconfitta in finale proprio da Coco Gauff. Le statistiche di quel match sono impietose per la bielorussa: 70 errori non forzati contro 30 vincenti. A Wimbledon, qualche settimana dopo, mentre Sinner e Alcaraz stavano per giocare la loro seconda finale Slam consecutiva, Sabalenka veniva sconfitta da Amanda Anisimova, che in finale avrebbe perso 6-0, 6-0, in meno di un’ora da Iga Świątek.

Serena ha detto addio al tennis e si è portata via il testimone. Tipico: ancora una volta, anche da assente, ha occupato tutto lo spazio. O forse non è così assurdo pensare che l’eredità non spartita con le altre sia stato un gesto di altruismo, l’unico della sua carriera da giocatrice. Come se quel Serena’s Slam mai verificato fosse stato una presa di consapevolezza: è stato tutto bello (forse nemmeno tanto), è stato tutto troppo, in fin dei conti non ne valeva la pena. Le sue colleghe lo hanno capito anche grazie a lei: non lo vogliono quel testimone, significa troppe cose, non tutte da ricordare con il sorriso. Le sorelle Williams sono state una rivoluzione black nel mondo del total white. Hanno fatto conoscere Wimbledon fuori dai country club, nel ghetto. Il loro esempio ha fatto sì che bambine di origini, etnie, estrazioni sociali diverse scegliessero il tennis, sognassero di diventare un giorno come loro. È grazie a loro (a Venus soprattutto) se oggi le donne negli Slam guadagnano quanto gli uomini.
Ma forse la sua eredità, l’ombra che proietta su tutto il tennis femminile, si vede soprattutto nell’esempio che le nuove generazioni non vogliono più seguire. Nell’accettare il fatto che la sconfitta sia un’eventualità da vivere senza vergogna, nell’indossare un cappellino per nascondersi senza per questo essere meno numero 1, nel non farsi ossessionare, incattivire dallo sport. Esistono campionesse effimere, di passaggio, che però una volta nella vita sono state campionesse e nessuno potrà mai negarlo.

Quattro decadi di tennis non solo non le hanno regalato il Grande Slam, ma nemmeno la felicità. Lo ha spiegato molto bene lei stessa poco dopo la nascita della sua primogenita Alexis Olympia Ohanian, quando le hanno chiesto se avrebbe voluto che sua figlia diventasse una tennista. “Non glielo auguro”. Eccola l’eredità. Aver fatto comprendere alle altre giocatrici, grazie al suo esempio da non seguire, che non importano i record, le statistiche, il tuo nome in un elenco, uno dei tanti, non importa il dominio, le settimane consecutive in cui sei invincibile. Tanto non lo realizzi il Grande Slam. È solo fegato marcio. E allora tanto vale essere la tennista che meriti di essere. Senza testimoni da rincorrere. Con un’ombra da cui si impara a non farsi calpestare.
Giorgia Mecca è nata a Torino nel 1989. Gioca a tennis da quando ha memoria, e quando non gioca lo guarda. Collabora con Sky Sport, il Foglio e il Venerdì di Repubblica. Ha scritto un libro: Serena e Venus Williams, nel nome del padre (66thand2nd).
Segui Mezza Riga su Instagram. Se vuoi sponsorizzare questa newsletter, scrivi a: info@nredizioni.it





